
Sono tra quelli che sostengono che non possiamo andare avanti, non possiamo progredire e tentare di risolvere le minacce che attendono l'umanità con la testa girata all'indietro, sotto il peso di schemi etici arcaici e di tradizioni ormai prive di senso, se non quello di sentirsi appartenenti, non si sa bene a cosa e, in sostanza, di crearci una gabbia in cui pensiamo di essere al riparo da ciò che non comprendiamo o abbiamo difficoltà ad ammettere razionalmente. Questa gabbia artificiosa è poi quasi sempre gestita da istituzioni che hanno tutto l'interesse a mantenerla ben chiusa.
Ma sono anche tra quelli che sostengono che il futuro non bisogna praticarlo senza gli attrezzi forniti dalla prospettiva storica, senza gli strumenti di analisi utili per individuare i percorsi fatti e quelli da affrontare, per evitare di andare a sbattere nelle tragedie e di rendersene conto solo dopo che sono accadute.
Occorre insomma guardarsi da due tendenze piuttosto diffuse. La prima guarda alla storia con nostalgia, con la speranza di tornare indietro o almeno con rimpianto: tutto sarebbe già avvenuto, ciò che avviene si è già visto e ciò che intravediamo è una corruzione del passato e del presente. Così, se proprio non si può tornare indietro (perché non si può mai tornare indietro), almeno è forse possibile ricreare, a un livello diverso, qualcosa che gli somigli, che si possa riallacciare ai bei tempi andati.
La seconda tendenza guarda al presente e al futuro prescindendo dalla storia, anche recente: tutto sarebbe nuovo. È dall'inizio del Novecento che ci affligge la retorica del "nuovismo", la quale in realtà nasconde il desiderio di andare oltre ciò che c'è, ma senza sapere come e in quale direzione e, soprattutto, con quale bussola interpretare il mondo.
Sono queste alcune delle ragioni per cui occorre insistere nella riflessione sul Novecento, un secolo intricato, con tanti di quei contrasti tra luci e ombre da rendere difficile individuarne la caratteristica dominante. Se è vera l'ovvietà cronologica che il XX secolo è terminato e se è vero che il suo termine è segnato da alcuni cambiamenti che hanno radicalmente mutato la geopolitica, mentre altri mutamenti come la globalizzazione e le nuove tecnologie ci introducono a situazioni del tutto inedite dal punto di vista storico, se è vero tutto ciò, tuttavia le nuove generazioni non possono voltare pagina senza una sorveglianza continua e una critica di ciò che la storiografia francese delle Annales ha definito come permanenza della lunga durata.
Il tempo storico non è un costrutto compatto, è un insieme di tempi reali riguardanti ambiti molto diversi delle attività umane (e naturali) che non si risolvono e non cambiano tutti in una volta ma con scarti temporali molto diseguali, alcuni di durata secolare. Per non parlare qui del problema dei tempi biologici ed evolutivi, della cosiddetta naturalità e dell'artificialità, che ci introducono a ciò che possiamo chiamare il mutamento antropologico. Ora, questi tempi diversi di svolgimento non sono meno importanti, anzi lo sono quasi sempre di più, di quella che, sempre gli storici francesi delle Annales, hanno definito l'histoire événementielle, ossia il racconto e l'interpretazione storici ristretti agli eventi politici e più, come dire, di superficie delle vicende umane1. La storia tradizionale, insomma.

Questa introduzione era necessaria per parlare del libro dello storico inglese Jeremy Black
[Il mondo del ventesimo secolo, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 325], che ha pubblicato, tra l'altro, il più recente La guerra nel mondo contemporaneo, edito sempre da il Mulino. L'autore, infatti, si sforza di individuare gli aspetti rilevanti del Novecento che di solito non vengono affrontati dalle storie politico-militari, se non con riferimenti di circostanza. Dico subito che nel libro ci sono alcune forse inevitabili omissioni e che l'inventario dei fattori di mutamento più profondi è però poco legato alla storia degli eventi, quelli della storia-racconto. Per la verità, lo stesso storico scrive nelle conclusioni che ciò è precisamente la dimostrazione di quanto il mondo della politica "non ha affrontato i problemi del mondo". Forse esulava dai suoi compiti tentare una tale ricucitura, ma la scarsità degli approfondimenti analitici sulle ragioni per cui è avvenuto ciò che è avvenuto lascia senza risposta diversi interrogativi. Insomma, se il libro è un utilissimo prontuario dei problemi del Novecento che si dispiegano ancora prepotentemente nel secolo nuovo, rimane al lettore tutto l'onere di formulare ipotesi interpretative. Che è poi esattamente il problema su cui si sta balbettando e per di più con incursioni scarsamente collegate a una visione complessiva del sistema civiltà umana in rapporto al futuro. Anche gli storici dovrebbero aiutarci in questo, ma la storiografia empirica dell'autore non ci consegna un metodo adeguato, una chiave soddisfacente di lettura.
Jeremy Black inizia la rassegna dalle questioni ambientali, dalla "sfida alla Terra" che il Novecento (con le sue radici nelle epoche immediatamente precedenti) ha lanciato con il suo enorme, accelerato e dissipante (per le risorse naturali) sviluppo produttivo, con l'incredibile successo della specie umana derivante dall'esplosione demografica, con la totale "mercificazione dell'ambiente". Le sue conclusioni mi sembrano da condividere quando osserva che è stato ormai "messo in luce un processo secolare di causa ed effetto, a fronte del quale sono state chieste decisioni politiche basate sulle conoscenze e sul dibattito scientifici. Eppure, nello stesso tempo, per molti governi né quei processi causali secolari né la decisione politica informata dalla conoscenza scientifica erano una realtà". In buona sostanza, per l'autore è possibile che le generazioni future ci giudicheranno soprattutto per gli enormi danni fatti all'ecosistema. Il Novecento verrà ricordato come il secolo della sconfitta dei totalitarismi (come pure è stato) o come il secolo della sconfitta della Terra?
Non serve ripercorrere qui la rassegna dei danni ambientali che abbiamo fatto e che dopo i recenti rapporti di Parigi degli esperti dell' IPCC dell'ONU (Intergovernmental Panel on Climate Change) e il conseguente Appello [versione tedesca e italiana] sottoscritto da quaranta paesi, appaiono condivisi in modo consolidato dalla comunità scientifica. Gli scenari che sono davanti ai nostri figli e nipoti sono sconvolgenti, con effetti difficilmente calcolabili, ma prevedibili, dal punto di vista del cambiamento degli assetti politici, della vita quotidiana, dei rapporti economici e civili, dei rapporti internazionali.
Il punto è che probabilmente è ormai superata la soglia del non ritorno e che tutte le misure immaginate fin qui, seppure necessarie (dalla ancora incerta e reticente formula dello sviluppo sostenibile alle pur moderate e non da tutti condivise misure previste nel protocollo di Kyoto) non serviranno comunque a ristabilire la situazione. Quindi o la civiltà umana adotterà costosissime e problematiche misure di ingegneria planetaria (di cui peraltro non è possibile prevedere con sicurezza gli effetti) e che non potranno comunque essere affrontate con gli attuali assetti politico-economici, oppure il controllo della situazione, la gestione delle emergenze e la rapida conversione del cosiddetto modello di sviluppo su scala planetaria potrà generare traumi e esiti politici oggi difficilmente immaginabili. Ma non mi pare che si stia preparando l'opinione pubblica (né l'economia) ad affrontare questa dimensione del problema, nonostante le solenni dichiarazioni sottoscritte a Parigi e i buoni propositi dell'Unione Europea.
Certo, è difficile convincere la gente a cambiare stile di vita e di consumo, per non parlare del fatto che è ancora più difficile opporsi alla giusta rivendicazione delle popolazioni meno favorite verso un più elevato livello di vita. Quale sarà l'autorità in grado di imporre un cambiamento di rotta al complesso della vita sociale e alle attività economiche del mondo? E poiché l'impatto del cambiamento climatico del pianeta non produrrà dovunque gli stessi effetti, quale sarà la strada per compensare, mediare, riequilibrare le diverse situazioni territoriali? Il filosofo Hans Jonas, immagina come unica soluzione possibile una sorta di direttorio universale composto da un livello di saggi (i filosofi?), un secondo livello con potestà elaborative (gli scienziati), e un terzo investito del potere operativo (i politici), i quali dovrebbero in sostanza eseguire quel che dicono gli altri due, ma sapendo che "soltanto un massimo di disciplina sociale politicamente imposta è in grado di utilizzare la subordinazione del vantaggio presente alle esigenze di lunga scadenza del futuro". Mi pare che si proponga una soluzione simile alla Repubblica di Platone, che non è deprimente solo finché rimane confinata alla storia della filosofia2. Comunque, non serve a nulla essere catastrofisti, il pessimismo non aiuta a trovare soluzioni che permettano il superamento della crisi. Tra apocalittici e integrati, preferisco la definizione di preoccupati. Né serve il prendersela con la tecnica, invece che con chi decide le sorti del pianeta: si tratta di uno stucchevole meccanismo filosofico novecentesco che demonizza ciò che non capisce, quando poi parte della speranza di farcela non può che affidarsi alla scienza e alla tecnica. Ma si deve cominciare dal riconoscimento che di una crisi assai seria si tratta, forse la maggiore che l'umanità abbia mai dovuto affrontare. E anche che ci dobbiamo misurare con problemi che richiedono alla politica di immaginare che cosa è oggi l'interesse generale non contingente e come difenderlo, in un'epoca in cui la storia è divenuta davvero universale. Per questo secondo aspetto sono un po' meno ottimista: la politica è difficilmente in grado di immaginare e impostare soluzioni a lungo termine, come appare necessario. Per ora, l'unica proposta in campo per governare il cambiamento è la costituzione di un ONU per l'ambiente.
Così, nel continuare la rassegna di Jeremy Black, un identico allarme deriva da tutto ciò che è stato prodotto nel Novecento per quanto riguarda l'attuale e disuguale ripartizione delle risorse naturali della Terra. Un mondo affollato e sempre più squilibrato, che ha vinto molte malattie ma che deve affrontarne di nuove a causa delle mutazioni genetiche dei virus; che è in generale riuscito a incrementare le speranze di vita ma non in tutto il mondo. La quasi completa antropizzazione della Terra e la crescita smisurata delle città, la rivoluzione dei mezzi privati di trasporto e delle comunicazioni, inoltre, starà forse già determinando un cambio del passo evolutivo non solo per l'uomo ma per tutto il vivente, di cui è impossibile immaginare l'esito. Osservazione, quest'ultima, che non è dell'autore.
Le appartenenze etniche e sociali, per il nostro storico, sono l'altro fattore strutturale che ha connotato il Novecento. L'interpretazione-utilizzazione che si è fatta di queste categorie ha condizionato il suo svolgimento politico-militare, ma anche la sfera sociale e privata. Il caleidoscopio dei mutamenti sociali non termina certo qui. Esso ha riguardato, come sappiamo, anche la questione del genere e quella dell'avanzamento dei diritti in diversi campi, così come lungo tutto il secolo si sono confrontati modelli estremi riguardanti il controllo sociale, con un conflitto pressoché permanente tra nazionalizzazione e libera iniziativa, tra individualismo e sfera comunitaria, tra secolarizzazione del mondo e riaffermazione della spiritualità sotto varie forme, con un andamento quasi ciclico, se guardiamo a ciò che è accaduto facendo scorrere un sufficiente nastro temporale. La diffusione di modelli di consumo ma anche culturali (culture giovanili, ad esempio) sottolineano infine la varietà delle esperienze novecentesche ma anche ("sia pure con gradi di realizzazione ineguali") il moltiplicarsi dei modelli di convivenza e l'entrata in crisi dei rapporti sociali e familiari tradizionali. Sia che si parli dello sviluppato nord del mondo, sia che si guardi alla disgregazione dovuta a povertà e malattie in altre aree del pianeta.
Naturalmente, la vicenda economica non è per l'autore "un semplice accessorio degli altri temi, ma è anzi un argomento di importanza fondamentale, che deve essere trattato in un capitolo apposito". La periodizzazione dei cicli economici utilizzata nel libro è quella tradizionale, così come già note sono le osservazioni sui rivoluzionamenti produttivi avvenuti nel corso del secolo. Una ricognizione dei principali cambiamenti avvenuti nelle economie regionali e nei mutamenti dei rapporti di scambio tra i diversi blocchi continentali e sub continentali ci permette di riassemblare un insieme di dati e di eventi, per arrivare alle soglie del nuovo secolo. Direi però che manca qui un'efficace analisi del fenomeno della globalizzazione, che rappresenta uno degli elementi di maggiore novità che il Novecento ci ha consegnato, con tutte le implicazioni geopolitiche, militari e anche etiche che ne conseguono. Certo, l'autore non manca di segnalare come, nonostante il grande avanzamento economico e anche l'uscita di interi popoli dall'indigenza, il problema della povertà e della sua iniqua distribuzione su scala mondiale rappresenti uno dei problemi più gravi e irrisolti. I dati della Banca mondiale sono sbagliati per difetto a causa della composizione del paniere adottato per calcolare in termini equivalenti il costo della vita; vi sono infatti inseriti beni che i poveri non comprano e servizi che nei paesi del terzo mondo costano assai meno. Il numero reale delle persone povere ascenderebbe perciò al 30-40% della popolazione mondiale. Aggiungo, però, che appare poco sviluppato il tema delle crisi monetarie e delle misure che, in regime di ultraliberismo, sono state adottate per tamponarle, dopo averle provocate3. Il ruolo del macchinismo che in una prima e prevalente parte del Novecento ha condizionato modi di produrre (il fordismo) e concezioni politiche, ma anche il ruolo delle nuove macchine nell'ultima parte del secolo (nuove tecnologie) sono trattati nel settimo capitolo. Debbo dire che mi è sembrato piuttosto riduttivo non affrontare la questione della scienza (come anche dell'arte) in un capitolo apposito. Non che non ci siano nel testo numerosi riferimenti e osservazioni in proposito, ma inserire questi argomenti in altri contesti rischia di oscurare il fatto che attorno alla rivoluzione tecnico-scientifica permanente ormai iniziata da qualche decennio - per non tacere del ruolo delle grandi scoperte scientifiche novecentesche - si giocano molte delle questioni che condizionano e condizioneranno sempre di più la civiltà umana.
Nel testo segue poi una rassegna delle tendenze culturali con specifico riguardo alla domanda: "umano o divino"? Ideologie laiche e ideologie religiose si sono confrontate, intrecciandosi a processi democratici e totalitari, all'espansione del ruolo degli Stati, alla tensione permanente tra individualismo e egualitarismo.
L'ultima parte del libro si occupa del rapporto tra politica e guerra, ripercorrendo ovviamente le tragedie che hanno funestato il Novecento, fino alla caduta degli imperi (coloniali e di fatto) dell'ultimo cinquantennio, ivi compresa l'Unione Sovietica. Ma, osserva l'autore, si "era ottenuta una libertà che non aveva realizzato le speranze del liberalismo. Invece di quel futuro all'insegna del progresso che si era immaginata, si era vista sorgere una situazione gravida di minacce, considerata da molti come una regressione a un passato buio".
Le conclusioni, che si affacciano ovviamente sul secolo attuale, nonostante tutti i miglioramenti avvenuti e riconosciuti per miliardi di esseri umani, non sono improntate all'ottimismo, sottolineando ancora una volta il tema del disastro ambientale e la responsabilità delle ideologie del Novecento, al termine del quale "si constatava che l'espansione, pianificata o non pianificata che fosse, sfociava alla fine non solo in inconvenienti particolari, ma, più in generale di un pernicioso assalto a un ambiente globalmente interdipendente". L'autore sembra pensare che da sola l'umanità riuscirà difficilmente a farcela. Tanto da osservare che tutte le storie generali del Novecento trascurano una questione e cioè che "il mancato incontro con forme di vita extraterrestri ha evitato che ci si dovesse interrogare sulla natura relativa dei valori umani".
A pensarci bene non è una cattiva idea, in un periodo in cui riemergono concezioni assolute e integralismi all'insegna dell'antirelativismo. Un abito mentale che pensasse le presenze del mondo e dell'universo non limitate alle nostre flora e fauna e a noi stessi, non ci farebbe male.
Entrare nella storia del Novecento esaminandone l'anima nera che l'ha attraversato, significa fare immediatamente i conti con "lo spettro del genocidio, che ha sconvolto con tanta furia il XX secolo, [e che] oggi assilla il mondo intero" – scrivono Robert Gellately e Ben Kiernan, concludendo la raccolta di saggi Il secolo del genocidio [Milano, Longanesi, 2006, pp. 509] che compongono il libro. Un testo importante, denso di riflessioni, informazioni e domande inquietanti che hanno a che fare con gli interrogativi sulla natura umana e anche con il destino delle prossime generazioni, considerando i veri e propri macigni che sono stati posti dal Novecento sul percorso della storia umana. Un libro di dolore, questo, nonostante il linguaggio storico, giuridico e sociologico utilizzato per esaminare e documentare ciò che di peggio è avvenuto in quel secolo.
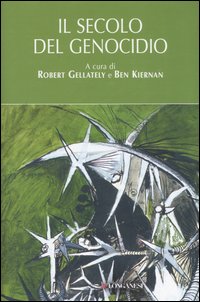
Il fatto è che ci trasciniamo ancora appresso non solo la lunga ombra dei genocidi del XX secolo e la loro ripetizione alle soglie del nuovo secolo, ma persino la negazione di alcuni di essi non solo da parte di studiosi revisionisti ma anche da parte di Stati che fanno parte del consesso internazionale. Come il Giappone o la Turchia che continuano ad oscurare o a minimizzare i genocidi degli Armeni o in Manciuria e in Corea.
Nel caso turco, una legge del 2004 ha stabilito che "la richiesta di riconoscimento del genocidio degli armeni" è un reato di cospirazione nazionale. Questa mancata ammissione dell'avvenuto genocidio – richiesto anche dal Parlamento europeo nel 1987 - è una delle cause di tensione con l'Unione Europea. È nota la reazione della Francia che ha adottato una legge, duramente contestata dalla Turchia, che punisce chi nega il genocidio armeno. Stiamo parlando di due successive vicende genocidiarie (1894 e 1915) che, secondo gli storici più accreditati, hanno prodotto tra i cinquecentomila e i due milioni di morti. La cifra di un milione e mezzo di morti è quella più diffusa. Se si considera poi, come viene messo in rilievo nel saggio di Jay Winter su Il genocidio armeno nel contesto della guerra totale e in quello di Omer Bartov su Cercando le radici del genocidio moderno, che quello degli Armeni – per ragioni che sarebbe qui troppo lungo riferire - ha fornito un modello di riferimento al successivo Olocausto nazista (alcuni storici parlano di Olocausto armeno), si comprende bene come la questione non sia astratta ma tocchi direttamente le culture e le tradizioni di popoli che dovrebbero far parte di un condiviso modo di sentire. Anche se dal punto di vista della dimensione delle vittime e delle tecniche impiegate (ma non della ferocia dispiegata) c'è uno scarto tra ciò che hanno compiuto i nazisti e ciò che i Giovani Turchi al governo decisero di fare, sarebbe un po' come se in Germania si proibisse per legge di parlare dell'Olocausto.
In Giappone, invece, si tende a giustificare la morte di milioni di cinesi e l'asservimento totale della Corea come un increscioso sottoprodotto della guerra. Del resto, gli eccidi compiuti dall'esercito imperiale non sono casi isolati nel mondo moderno – sostengono le autorità e gran parte dell'opinione pubblica giapponese; e trovano infatti molti appigli alla loro reticenza ricordando che ci sono stati nel Novecento anche altre efferatezze che vengono passate sotto silenzio o giustificate. Come lo stesso olocausto nucleare compiuto dagli Stati Uniti a Hiroshima e Nagasaki o i massacri coloniali francesi, belgi, olandesi, italiani e anche britannici. Tutte vicende per le quali non ci sono state scuse né il riconoscimento di colpa, salvo, mi pare, nel caso dell'Australia e dei suoi tentativi di estinguere gli aborigeni.
Insomma - sembrano dire quei paesi reticenti - si è talmente in cattiva compagnia che non è proprio il caso di mettere sotto la lente di ingrandimento l'uccisione di più di un milione di Armeni e le indicibili atrocità compiute dai Giapponesi in Estremo Oriente.
Ora, è evidente che l'obiezione giapponese che non sia giusto escludere dalle categoria del genocidio o dell'eccidio di massa le molte malefatte perpetrate dai paesi occidentali ai danni di numerosi popoli e, in particolare, gli orrori delle guerre coloniali, ha un suo fondamento. Per cui, la richiesta al Giappone di riconoscere le proprie responsabilità risulterebbe del tutto ipocrita e unilaterale. Ma il punto, per la Turchia come per il Giappone, non è quello di potersi nascondere dietro le infamie compiute dagli occidentali, ma di fare per davvero i conti con il proprio passato, come mi pare che solo la Germania abbia fatto per davvero, anche attraverso le migliaia di verdetti di colpevolezza emessi dai tribunali tedeschi.
A onor del vero, negli ultimi decenni il Giappone sembrava aver fatto qualche passo avanti con inchieste giornalistiche e opere di storici che hanno messo a fuoco ciò che l'esercito imperiale ha perpetrato dagli anni Trenta fino al termine della Seconda guerra mondiale, come riconosce anche Gavan McCormack nel suo saggio Riflessioni sulla storia contemporanea del Giappone nel contesto del concetto di genocidio. Tuttavia, i governi conservatori degli ultimi anni hanno tentato di ignorare o cancellare il problema, con i ripetuti omaggi del primo ministro del tempo (e di ottanta parlamentari), compiuti nel cimitero militare giapponese di Yasukuni, dove sono sepolti anche i criminali responsabili degli eccidi. Sarebbe come se un cancelliere tedesco si recasse a rendere omaggio al cimitero in cui fossero sepolti i massimi gerarchi nazisti.
Ora, occorre ricordare che il massacro dei cinesi non fu certo limitato alla sola città di Nanchino, della quale soltanto si tende a parlare. Tutta la parte di Cina occupata è stata il teatro di una Nanchino moltiplicata, ivi compreso l'uso di forni crematori e gli esperimenti sugli esseri umani, testando armi chimiche e biologiche (la famigerata Unità 731). Una guerra non dichiarata e perciò non assoggettata al diritto internazionale fece in Cina e in Corea (dove il Giappone "perseguì con assoluta coerenza l'estinzione della Corea in quanto unità nazionale") un numero di morti civili forse superiore a quello causato dalla Germania nazista.
Certo, in quel quadrante mondiale il precedente degli eccidi di massa moderni era stato inaugurato dagli Stati Uniti con i massacri compiuti nelle Filippine. Ma il comportamento genocidario giapponese non sbucò dal nulla, non rappresentò solo uno sciagurato episodio del sanguinoso Novecento: affondava le proprie radici nella storia delle relazioni tra il Giappone e la Corea. Se il Tribunale militare internazionale che iniziò i suoi lavori a Tokyo nel 1946 non giudicò genocidario il tentativo dei Giapponesi di cancellare radicalmente l'identità dei coreani e di utilizzare praticamente come schiavi almeno un milione di giovani e di usare centinaia di migliaia di donne coreane come donne di conforto per le truppe, fu perché "le azioni criminali giapponesi non si differenziavano dalle violenze perpetrate nel corso della storia del colonialismo".
In sostanza, solo a partire dal passaggio fondamentale di un'ammissione collettiva dei genocidi compiuti (e non di soli eccessi dovuti alla guerra), quei paesi possono dotarsi di una nuova innocente autorevolezza morale per pretendere che anche gli altri, compresi gli Stati Uniti, facciano i conti con se stessi. E magari pretendere che vengano riesaminati criticamente, non solo dagli storici, anche i crimini coloniali e bellici. Dai quali l'Italia non è certo esclusa, nonostante il velo di silenzio autoconsolatorio steso dagli Italiani sulla propria storia di atrocità compiute (in Libia, in Eritrea, in Somalia, in Etiopia, in Slovenia) e riassunto nel mito fasullo degliItaliani, brava gente4.
È stata la vicenda del colonialismo a fare da battistrada e da maestra al fiume di sangue che ha attraversato il Novecento. Isabel V. Hull nel saggio Cultura militare e soluzioni finali nelle colonie, sostiene che "non è un caso che i più radicali fautori dell'imperialismo fossero i primi a saldare in un'organica concezione del mondo il razzismo moderno, l'antisemitismo, uno spietato darwinismo sociale, il sogno della dominazione totale, la militarizzazione della società e l'adorazione della guerra intesa come il migliore strumento (o addirittura il fine) della politica".
È chiaro che, indipendentemente da ciò che faranno Turchia e Giappone a proposito della loro memoria nazionale, gli altri massacri di massa non vanno comunque passati sotto silenzio e che spetta agli occidentali non meno che agli altri il compito di costruire un nuovo ordine mondiale basato su un esame critico del passato. Cosa della quale, per la verità, non si vedono che scarsi esempi a livello degli Stati.
Perché (questo vale in generale e per ogni caso), se non si fanno i conti con il proprio passato, se le nuove generazioni crescono al riparo della menzogna e della reticenza, diventa legittimo il dubbio che esista una coazione a ripetere e che sotto la riverniciatura democratica di molti paesi della seconda metà del Novecento l'impersonale bestialità di una barbarie senza nome possa ripresentarsi, magari sotto forme nuove. Il che, peraltro, vale (e forse a maggior ragione) anche per le più antiche e consolidate democrazie, specialmente se vogliono presentarsi come gli alfieri di un ordine mondiale giusto.
"L'Europa - per Elazar Barkan, autore del saggio Genocidi di popoli indigeni. La retorica dei diritti umani – è responsabile, a dire il meno, di aver chiuso gli occhi, di non aver riconosciuto l'uguaglianza dei popoli indigeni e l'enorme numero di atrocità inflittegli; di aver volontariamente negato la propria colpevolezza, di essersi nascosta dietro la spiegazione strutturale dei fattori biologici".
Tra le tante interpretazioni storico-giuridiche di genocidio che si sono succedute negli anni (a partire dalla Convenzione dell'ONU del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio) e tra gli interrogativi sollevati sulla novità o meno del fenomeno nella storia umana, mi convince la tesi di quegli studiosi che collegano la nascita del genocidio al fenomeno del colonialismo e alla Prima guerra mondiale5. Perché, "secondo questa interpretazione plausibile e valida, la modernità del genocidio risulta non solo l'elemento più agghiacciante ma il suo connotato essenziale che lo diversifica dagli eccidi di massa di epoche passate." Senza con ciò cancellare lo sterminio dei nativi americani compiuti prima nel Novecento, atto che potremmo comunque considerare come l'alba del colonialismo contemporaneo. L'imperialismo europeo, ma anche l'antisemitismo cristiano, innescarono – secondo Hanna Arendt, le cui tesi sono attualmente rivalutate – i fenomeni genocidari che hanno funestato il Novecento6.
Questa è una delle ragioni più forti per cui l'ombra di quel secolo si allunga ben dentro quello nuovo nelle terre ex coloniali e nei paesi che hanno subito l'egemonia e l'occupazione armata delle potenze imperiali occidentali. Anche per questo mi pare superficiale e autoconsolatorio dire che "il Novecento è finito", con il rischio di non individuare le radici dell'attuale terrorismo7.
Il risalto dato a un solo evento per segnare la fine del secolo, per quanto grandioso (come ad esempio il crollo dell'Unione Sovietica e la fine dell'utopia comunista realizzata), non può riassumere e cancellare ciò che di tremendamente vivo si annida nelle viscere della storia in marcia. Quasi che i fattori che hanno determinato l'avvento delle società di massa, l'affermazione degli Stati nazionali e di una nuova inaudita potenza tecnologica, con tutte le loro contraddizioni, siano scomparsi.
Tanto più che il secondo Novecento, nonostante i genocidi nazisti e i massacri di massa perpetrati dallo stalinismo, figlio legittimo del leninismo - come giustamente ci ricorda Valerio Castronovo, del cui libro parleremo più avanti – ha continuato a perseverare nelle stragi di massa (alcuni dei veri genocidi).
Sono diversi i saggi che prendono in esame alcuni dei massacri del secondo Novecento, i decenni in cui l'equilibrio atomico del terrore e un'Europa politicamente e militarmente sterilizzata sono riusciti a non produrre una nuova guerra mondiale. Si discute ancora se alcune di queste esecuzioni di massa siano classificabili come genocidi, perché la Convenzione del 1948 – a causa dell'opposizione dell'URSS – non incluse in questo crimine l'eccidio politico di massa. I milioni di morti conseguenti alle politiche maoiste o i massacri di massa in Guatemala – esaminati nel saggio di Grag Grandin su Il genocidio degli anni 1981-1983 in Guatemala e giudicati poi su mandato dell'ONU - non possono dirsi ormai alle nostre spalle perché i regimi del tempo continuano attualmente senza aver fatto i conti con il proprio passato.
Sappiamo bene di quali crimini è costellata l'ultima parte del Novecento. Del milione di persone brutalmente uccise a Bali dagli indonesiani del generale Suharto nel 1965 e delle centinaia di migliaia di persone deportate e uccise sempre dagli Indonesiani a Timor est, gli occidentali si sono disinteressati per decenni. A Bali si trattava di militanti, parenti, conoscenti anche casuali, dei comunisti, riferiscono Leslie Dweyer e Degung Santikarma nel loro studio Quando il mondo piombò nel caos, il cui titolo è l'espressione con cui i locali si riferiscono ancora a quel periodo. Come osserva John G. Taylor nel saggio L'occupazione indonesiana di Timor est, "per ventiquattro anni gli occidentali fecero finta di ignorare il sistematico massacro, tollerarono, scusarono e a volte appoggiarono l'occupazione indonesiana di Timor est".
Ma nell'ultima parte del secolo c'è stato anche il genocidio cambogiano diretto dal delirio di Pol Pot e delle sue bande, che si rifacevano al maoismo e che cercavano di fare tabula rasa di ogni simulacro di società moderna e di riportare il paese a una presunta purezza contadina (e razziale) facendo milioni di vittime, analizzato nel saggio di Edward Kissi Genocidio in Cambogia e in Etiopia.
Qui in Europa, proprio nel continente che ha prodotto due guerre mondiali, un Olocausto e le guerre coloniali, è ancora recente e aperta la ferita delle pulizie etniche balcaniche, descritte nel saggio di Jacques Semelin su La pulizia etnica dell'ex Iugoslavia (1991-1999). Sono questioni di cui si discute ancora animatamente e che registrano inaccettabili posizioni di equidistanza. Dal mio punto di vista, proprio l'orrore della pulizia etnica giustifica l'intervento in Kosovo e condanna il ritardatario e inadeguato comportamento europeo, americano e dell'ONU nelle stragi avvenute in Bosnia. "Dove i massacri non furono anarchiche eruzioni di odi antichi o il risultato dell'azione di individui o gruppi che rispondevano dei loro comportamenti; erano parte integrante di una politica rivoluzionaria incentrata sulla riplasmazione del corpo sociale" – scrive Eric D. Weitz in La modernità dei genocidi. Guerra, razza e rivoluzione nel Novecento. Per non parlare delle responsabilità della Germania e del Vaticano nell'accelerare il processo di dissoluzione della Iugoslavia, all'insegna di un'irresponsabile improvvisazione e di interessi economico-religiosi.
Così come l'orrore del massacro dei Tutsi in Ruanda da parte degli Hutu registra due questioni che richiedono una più approfondita riflessione, come propone Robert Melson in Genocidio moderno in Ruanda. In primo luogo il fatto che i genocidi prodotti da una ideologia razzista non sono sempre accompagnati dalla potenza tecnologica, perché in questo caso migliaia di persone armate di machete, bastoni chiodati e armi da fuoco leggere hanno fatto tra il mezzo milione e il milione di vittime. Ciò che poi è confermato è che dietro gli eccidi di massa c'è sempre la direzione e l'istigazione di uno Stato. Ma qui c'è anche da aggiungere che è stata la potenza coloniale belga, seguita a ruota dalla chiesa cattolica, a teorizzare a suo tempo un'artificiosa divisione tra due raggruppamenti di stirpe bantu (Tutsi e Hutu) che esprimevano differenze socio-economiche e non etniche. E ciò, ai fini di un più efficace controllo di una società che gli occidentali stentavano a comprendere, per cui inventarono che l'aristocrazia bantu proveniva dall'Etiopia. Altro che le antiche rivalità tribali spacciate da gran parte dei media occidentali! Con il tempo, questa artificiosa suddivisione è stata interiorizzata, fatta propria dagli Hutu.
Questa partecipazione di massa ai genocidi o per via diretta o come creazione di un contesto popolare favorevole è esaminata in alcuni saggi. Per cui, a proposito dell'Olocausto nazista, Omer Bartov si chiede come mai "mentre in buona parte dell'Europa orientale i tedeschi non ebbero difficoltà a scatenare una stupefacente ondata di violenza locale contro gli ebrei, nell'Europa occidentale non fu così".
In diversi saggi, infine, vengono fatte ipotesi abbastanza convergenti sull'origine e la fenomenologia del genocidio, inteso come evento da mantenere separato dal massacro o dall'eccidio proprio per non diminuirne la gravità e per le caratteristiche specifiche che possiede.
In generale, guardo con sospetto tutte le utilizzazioni di espressioni e di concetti scientifici, specialmente di origine biologica, che vengano applicati, soprattutto in senso metaforico, a cose che con la scienza non c'entrano, come la società o la politica. Del tutto diverso e, anzi, necessario è il percorso che cerca di spazzare via costruzioni ideologiche e pregiudizi consolidati mostrando quali siano i fondamenti della cosiddetta naturalità umana, spiegandone gli aspetti in chiave evolutiva. Dico cosiddetta naturalità umana perché, dopo Darwin e, ancora di più, dopo la costituzione dell'etologia e l'affermazione della biologia evolutiva si tratta di un concetto senza senso, usato a seconda delle convenienze etico-politiche.8.
Nel caso specifico, mi riferisco non solo alla nota e distorsiva interpretazione del darwinismo sociale, che non ha cessato di fare danni immensi ma anche all'idea di corpo politico che, secondo Marie Fleming, autrice del saggio Genocidio e corpo politico nell'era della modernità, "è presente nella struttura di tutti gli organismi politici moderni". Imboccare la metafora del corpo politico (riferito alla nazione o ad un gruppo etnico, per esempio), può trascinare immediatamente con sé l'armamentario storicamente connesso, che va dall'igiene (sociale), alla purificazione e pulizia, al rischio di contagio e di degenerazione, all'identificazione del portatore di germi, il quale può così di volta in volta essere definito un insetto nocivo, una parassita, uno scarafaggio, un pidocchio, tutti insetti che, naturalmente, debbono essere estirpati. Sono, queste, solo alcune delle espressioni comunemente usate dagli assassini nei genocidi avvenuti nel corso del Novecento: dall'Olocausto alle purghe staliniane, a Pol Pot, alla pulizia etnica nei Balcani, al massacro dei Tutsi nel Ruanda. Tutte muovono dall'idea che il corpo politico costituito da una etnicità vera o presunta (o da un gruppo politico) possa essere infettato dall'altro, dal quale quindi occorre liberarsi senza tanti complimenti. La tesi dell'autrice, che esamina diverse interpretazioni del genocidio date da storici e da filosofi, è che è prevalsa l'idea di un corpo politico che deve essere orientato alla crescita e alla salute, di cui dunque "bisogna scongiurare il declino e il disfacimento". Il corpo politico, come simbolo della sovranità, insomma, "è il centro su sui è imperniato il genocidio, quindi la sua ripetibilità".
Tutto ciò significa che occorre tenere sempre sotto attenta osservazione i sistemi politici e i linguaggi usati. Per cui, riprendendo una frase di Theodore W. Adorno, dobbiamo "organizzare il [nostro] agire e pensare in modo che Auschwitz [ma anche la Cambogia, la Iugoslavia e il Ruanda] non si ripeta, non succeda niente di simile". Perché temo che questa traiettoria del Novecento non sia affatto terminata.
Un libro molto complesso e, inevitabilmente, già superato dagli eventi in alcune sue parti e affermazioni (come nel caso della politica estera americana, che nel frattempo è profondamente mutata), ci introduce ad una riflessione sul Novecento più strettamente intrecciata al XXI secolo. Si tratta dello storico Valerio Castronovo, L'eredità del Novecento. Che cosa ci attende in un mondo che cambia [Torino, Einaudi, 2000], il quale ha poi aggiornato le sue riflessioni, in modo più mirato, con opere successive.

I temi trattati sono molto vasti e, nel lodevole sforzo di completezza, il lettore talvolta rischia di perdersi. Ma, come scrive l'autore all'inizio, "non si può [...] comprimere l'itinerario di un secolo contrassegnato da tante e così peculiari vicende entro uno schema esplicativo omogeneo e lineare: come se il suo percorso recasse esclusivamente o quasi l'impronta di un determinato fenomeno storico di grande rilevanza, tale per sé da rappresentare in termini emblematici il denominatore comune e il senso ultimo del Novecento". Affermazione che condivido in pieno, come mi pare di aver già osservato.
Ma, se la storia politica è in qualche modo riassuntiva della storia umana (affermazione che Jeremy Black, come abbiamo visto, non condividerebbe), allora il crinale decisivo del Novecento sarebbe quello della vittoria della democrazia sui totalitarismi. Ipotesi certamente fondata, se non fosse che il conflitto non è affatto terminato e che sulla salute attuale della democrazia si nutrono fondati dubbi.
È francamente molto difficile riassumere il senso dell'opera, per cui mi limiterò a sottolineare alcuni punti che a me paiono salienti.
L'autore, è poco convinto della definizione del Novecento come secolo breve, data da Eric Hobsbawm9. Personalmente tendo ad essere d'accordo, sembrandomi riduttivo il restringimento della vicenda storica del secolo alla nascita e alla fine dell'Unione Sovietica. Intanto:
1. stanno riemergendo alcuni fantasmi del passato, come l'antisemitismo, la xenofobia e il razzismo; ma anche una nuova funzione delle religioni;
2. gli straordinari progressi tecnologici e scientifici, compiuti proprio a partire dal Novecento stanno ponendo problemi del tutto inediti;
3. il fatto che "capitalismo e democrazia appaiano oggi le strade che le società più avanzate dell'occidente hanno praticato" non assicura, osserva l'autore, una previsione simile per tutti i paesi del mondo;
4. il processo di globalizzazione e il predominio della grande finanza aprono molte incognite sul futuro governo del mondo e sulle prospettive di una democrazia economica, che non gode oggi di molto credito.
Aggiungerei la questione ambientale, come sottolineato da Jeremy Black, e che Valerio Castronovo affronta peraltro nell'ultimo paragrafo del libro con il significativo titolo Se gli uomini non salveranno Madre Terra. E quando l'autore scrisse il libro si discuteva ancora se ci trovavamo di fronte ad un cambiamento climatico radicale.
Insomma, "tutte le prospettive sono aperte e quel fenomeno di accelerazione della storia che ha caratterizzato il corso del Ventesimo secolo ha assunto negli ultimi tornanti cadenze ancor più concitate". Sicché, l'autore invoca uno sforzo straordinario per capire le differenze della situazione attuale rispetto alla prima e seconda rivoluzione industriale. Un tema che molti hanno cercato invano di sollevare nell'ultimo scorcio del Novecento, mentre la forza di una deriva politica e di una mentalità tradizionali (ma al centro ci sono corposi interessi economici e concrezioni storiche difficili da rimuovere), hanno vanificato la predisposizione tempestiva di strumenti di comprensione e di governo del mutamento. Parlo (l'autore parla) delle Ceneri del socialismo reale; del carattere e dell'invasività delle nuove tecnologie e della centralità assunta dalla scienza, fino alle soglie di una trasformazione antropologica (Nel labirinto multimediale e Fin dentro il segreto della vita); del profondo cambiamento della geopolitica con l'emergere di nuove aree e conflitti continentali di cui solo di recente ci si è accorti (Stati Uniti Europa e Asia a confronto); dell'esplosione della globalizzazione e della dimensione planetaria assunta dai problemi (Problemi a dimensione planetaria, per l'appunto); fino all'esigenza di ripensare radicalmente le funzioni dello Stato nazionale, anche in rapporto al Welfare, che in Italia è peraltro una caricatura dissipatrice e burocratica di altre esperienze nord europee (Il Welfare e i suoi retaggi).
Castronovo affronta di petto la questione del cosiddetto socialismo reale, ossia della torsione effettuata da Lenin della tradizione marxista, pensando che il socialismo fosse raggiungibile "indipendentemente dall'esistenza o meno nella società dei presupposti di una transizione verso il socialismo". A pensarci bene, questa impostazione mentale era molto coerente con il clima culturale del tempo, nutrito di volontarismo e di esaltazione della violenza. Ci sono radici teoriche sbagliate nello stesso marxismo - osserva l'autore – tuttavia mi pare ormai pacifico che lo stalinismo non è stato un fenomeno avulso dal leninismo ma un suo figlio legittimo, "anche se privo della stessa statura intellettuale". Bisognerà tornare su questo filone, perché i conti su questo problema, in Italia e altrove, non sono stati fatti per davvero: per reticenze e difficoltà di riesaminare la propria storia e perché fino all'ultimo molti hanno sperato in una "emendabilità" del sistema sovietico. E perché, al di là di certe previsioni marxiste contingenti e sbagliate, c'è da ragionare sul ruolo e sulla pericolosità delle utopie, come anche sul metodo storico-sociale e anche, almeno in parte, economico introdotto dal marxismo; il cui approccio sostanziale – senza magari che ce se ne accorga più – è diventato patrimonio analitico comune. Ma anche dal punto di vista del merito, il previsto ruolo della globalizzazione delle finanze, il rapporto inverso tra saggio di profitto e saggio del salario, la formazione dell'esercito di riserva del lavoro (flessibile), il ruolo del lavoro intellettuale, per fare solo alcuni esempi, sono stati confermati dalla storia. Un'altra questione non è certo da buttare a mare: mi riferisco al materialismo, ovviamente non nella forma ottocentesca e positivista ereditata, ma come razionalità critica. Già queste troppo sbrigative osservazioni sono l'annuncio di un ulteriore Labirinto. Lo storico, intanto, dichiara inconsistente la proposta della terza via, circolata qualche anno fa come transizione verso un mondo nuovo.
Qualche ondeggiamento dell'autore si verifica quando si affronta il tema dell'America di Reagan, il ruolo del monetarismo e dell'ultraliberismo e la tardiva e insufficiente risposta data dai progressisti. Anche a proposito del superamento del Welfare, che l'autore ha anche ragione di criticare, senza spiegare però che c'è stata in questo caso una specie di cortocircuito. Stefano Rodotà osservò qualche anno fa che il Welfare novecentesco non era solo figlio delle spinte e delle rivendicazioni popolari, ma anche la risposta del capitalismo e del liberalismo più accorti alla sfida sovietica, perché si doveva dimostrare che la democrazia era migliore della prospettiva comunista e perché in tale modo i ceti meno favoriti venivano incoraggiati a non guardare all'esperienza sovietica come a un modello di riferimento. Il cortocircuito fu dovuto alla pressoché contemporanea caduta dell'Unione Sovietica (la scomparsa del cane da guardia indiretto, se vogliamo), al mutamento dei modi di produrre (la fine del fordismo), favorito dalla rivoluzione tecnico-scientifica, e alla globalizzazione del capitale finanziario. Questo è quanto, anche se si sta cercando ancora di capire cosa è successo e cosa fare ora.
Certamente, l'autore ha ragione di sottolineare come nell'ultimo scorcio del Novecento "si è così determinata una vera e propria cesura rispetto al sistema di fabbrica sedimentatosi da mezzo secolo e talora anche più, a cominciare dagli esordi del fordismo". Ma mentre questa cesura non ha cancellato del tutto quel sistema, nemmeno in Occidente, ha però prodotto una ridislocazione delle attività produttive, ad esempio nei cosiddetti paesi emergenti come la Cina; accompagnata dai noti fenomeni locali da capitalismo ottocentesco (dietro il quale, però, ci sono le modernissime e ultratecnologiche multinazionali) che bisogna mettere bene a fuoco10.
Insomma, la questione ha bisogno di essere affrontata in modo più sistematico di quanto sia possibile fare in un volume così ampio. Sapendo che sempre dal cambiamento avvenuto dobbiamo partire e che dobbiamo guardare avanti.
Il capitolo in cui ci si interroga sulla possibilità di una nuova guerra fredda o di una coesistenza competitiva avrebbe bisogno di un aggiornamento, perché non ha potuto prendere in esame il problema di Bush e dei teocon americani (e non solo di quel paese). Comunque non c'è dubbio, come sostiene l'autore, che è la globalizzazione "che fa da scenario al nostro ingresso nel ventunesimo secolo". Proprio per questo, Castronovo sottolinea l'esigenza di un nuovo ordine mondiale, sia politico che economico e di una capacità planetaria di regolarne lo svolgimento, senza i quali l'opportunità rappresentata dalla globalizzazione si può trasformare in rischio. Ora, la speranza è che i danni già fatti non siano irreversibili dal punto di vista dei rapporti internazionali, oltre che dell'economia. E qui, tornano ancora le puntuali analisi di Joseph E. Stiglitz11.
Fra xenofobia e integralismo, che è anche il titolo di un paragrafo del capitolo dedicato alle migrazioni nel mondo e ai problemi di confronto e integrazione delle culture, il Novecento continua nel XXI secolo, con l'accentuazione dovuta a un fenomeno inarrestabile. Se, pur di fronte all'emergere di alcuni paesi da una secolare povertà, la distanza tra i paesi ricchi e quelli poveri è aumentata invece di accorciarsi; se il reddito complessivo delle duecento famiglie più ricche del mondo è pari a quello complessivo di circa il 40% dell'umanità (la quale ascende a 6.635.487.162 persone, nel momento in cui scrivo) e se il patrimonio dei tre uomini più ricchi del mondo equivale al prodotto interno lordo di quarantatre paesi, quasi tutti africani; se, per limitarci ad un solo quadrante del mondo, i milioni e milioni di posti di lavoro sempre più mancanti nei paesi dell'Africa subsahariana e del Sahel, derivanti dallo scarto sempre più accentuato tra crescita della popolazione (3% annuo) e risorse disponibili, rendono obbligata l'emigrazione, come osserva Letizia Mencarini in un articolo apparso su Neodemos.it; se circa il 20% della popolazione terrestre, la parte più ricca, consuma oltre il 70% di tutta l'energia richiesta a livello mondiale e se circa 2,5 miliardi di persone non dispongono di altra energia che quella derivante dalla legna o dalle biomasse; se, per descrivere sinteticamente solo una minima parte dei problemi che sono alla base degli squilibri mondiali, questa è la situazione, come si può pensare che l'esportazione della democrazia (magari con la forza) o i palliativi degli insufficienti e spesso sbagliati aiuti economici (poco meno di 84 miliardi di $, in diminuzione, contro i 1.120 spesi per gli armamenti, più di quanto si spendeva durante la guerra fredda: dati OCSE e SIPRI) possano risolvere i conflitti e le emigrazioni sempre più ampi?
L'autore, giustamente, invoca un New Deal contro la povertà mondiale, il che, immagino, richiederebbe un governo planetario, una ridistribuzione delle risorse, un mutamento delle ragioni di scambio, uno sforzo enorme nei campi sanitario e educativo e, di conseguenza, una regolazione dei livelli di consumo e di spreco dei paesi più ricchi. Al di là delle sfere di potere nazionali, propone Castronovo, e non si può che essere d'accordo. Ma chi convincerà il paese leader, gli USA (ma non solo, ovviamente, basti pensare alla Cina o alla Russia), a cedere una parte della propria sovranità senza andare incontro a una sollevazione popolare? Temo che il contadino del MidWest e l'uomo di Wall Street non saranno d'accordo.
Se poi, secondo un rapporto del 2006 della Freedom House, un centro di studi conservatore americano, le cose per la democrazia non vanno molto bene, perché seppure nel 46% della popolazione mondiale essa sembra essersi consolidata (con una valutazione a spanne che non ne prende in considerazione la qualità), nel 23% dei casi le cose vanno abbastanza male e nel 30% non c'è nemmeno l'ombra della libertà, si pensa ancora di esportare la democrazia con le armi e con le guerre di civiltà, oppure c'è qui una deriva pericolosa per il XXI secolo che richiederebbe ben altre politiche per essere scongiurata?
Una deriva che accumula spaventosi squilibri mondiali, assieme a una crisi ambientale dalle conseguenze inimmaginabili, a una rivoluzione della geopolitica, a una diffusione incontrollata del nucleare, a una radicalizzazione ideologica che utilizza le religioni. Ce n'è abbastanza per temere una spaventosa esplosione, considerando il processo di militarizzazione in atto, indotto dal terrorismo in alcune società occidentali.
Ora, per tornare al confronto ravvicinato tra ideologie religiose, costumi e tradizioni consolidate, comunitarismo e difesa della individualità della persona, stili di vita, stili politici e tradizioni che la globalizzazione obbliga a far convivere e a interagire (il che è una straordinaria opportunità nella storia umana) la domanda è il come e attorno a quali fondamenti e regole condivise ciò possa avvenire. E qui sopraggiungono i problemi, sia a livello geopolitico sia a livello di convivenza di popolazioni divenute ormai plurietniche. Sotto i nostri occhi c'è una cronaca conflittuale, aggravata dalla pretesa dei alcune religioni di avere l'ultima parola, a Oriente come in Occidente, di essere la camera giudicante di ultima istanza delle attività umane e degli stessi Stati, di imporre la propria visione dei fini ultimi del mondo e dell'etica anche a chi non ha nessuna intenzione di credervi, tanto più se soprannaturali, o a chi ne ha un'altra visione. Questo conflitto, che si alterna a tentativi di avviare un dialogo interreligioso, rischia di complicare tutto, oscurando le ragioni vere del malessere, per usare un eufemismo, che divide il mondo e incanalandolo verso uno scontro frontale, teorizzato dall'estremismo islamico e dalle varie salse in cui è stata condita la teoria occidentale dello scontro di civiltà.
All'autore sembra che l'unica e ragionevole strada per uscire fuori da questa stretta sia il rispetto dei diritti umani, tesi che è da condividere. Già, ma il problema è: quali diritti umani? Accenno soltanto a questo tema, così cruciale per il nuovo diritto di ingerenza negli affari interni dei singoli paesi, che dovrebbe scattare quando non siano rispettati i diritti umani. Ma occorre essere sicuri che tale ingerenza non rappresenti una variabile degli interessi di potenza - come troppo spesso avviene attualmente - e sia assoggettata a regole certe e condivise dalla comunità internazionale.
Di tutti i problemi sul tappeto a questo proposito, scelgo di fare una rapida incursione nell'islamismo, che l'autore affronta insieme ad altre questioni religiose, con qualche imprecisione.
Mentre la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che è il documento più universalistico adottato dagli Stati, appare talvolta al Vaticano troppo intriso di cultura liberale e illuminista (così come alcune deliberazioni dell'ONU riguardanti i cosiddetti temi sensibili12), ai paesi islamici essa appare come "una interpretazione laica della tradizione giudaico-cristiana", che non può essere attuata dai mussulmani senza violare la legge dell'Islam. Fu questa la dichiarazione dell'ambasciatore iraniano all'ONU nel 1981, alla quale seguirono delle dichiarazioni solenni dei paesi islamici coerenti con questa impostazione. L'ultima, adottata da tutti i ministri degli esteri dei paesi musumani nel 1990, è nota come Dichiarazione de Il Cairo sui diritti umani nell'Islam. Non c'è qui lo spazio per commentare in modo esauriente il documento. Basti dire, a postilla dei diritti umani fondamentali, che secondo il documento "ogni individuo ha diritto di essere giudicato in conformità alla Legge islamica e che nessun'altra legge gli venga applicata" [art 4.1.]; che "nessuno ha il diritto di costringere un Musulmano ad obbedire ad una legge che sia contraria alla Legge islamica" [art. 4.5]; che "nessuna accusa potrà essere rivolta se il reato ascritto non è previsto in un testo della Legge islamica" [art. 5.2]; che "ogni persona ha il diritto di pensare e di credere, e di esprimere quello che pensa e crede, senza intromissione alcuna da parte di chicchessia, fino a che rimane nel quadro dei limiti generali che la Legge islamica prevede a questo proposito. Nessuno infatti ha il diritto di propagandare la menzogna o di diffondere ciò che potrebbe incoraggiare la turpitudine o offendere la Comunità islamica" [art. 12.1]. Tutti i diritti affermati, anche quelli che riecheggiano o somigliano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sono applicabili nei limiti in cui non contraddicono la legge islamica (shari'a), ossia il Corano e la Sunna (gli atti e detti del Profeta). Il che avviene assai spesso. Per fare un solo esempio, è considerata una turpitudine o forse una menzogna non credere nella divinità e dirlo. Insomma, c'è un problema di libertà di espressione, per cui puoi dire tutto quello che vuoi purché sia coerente con la tradizione islamica.
In forme meno radicali e più aggiornate, questa impostazione non è certo sconosciuta in Occidente e, in particolare, in Italia. Certo, qui si può cambiare religione senza incorrere nelle ire della legge e persino essere atei senza, in quanto tali, essere minacciati di morte da un imam torinese estremista. Ma la pretesa religiosa di imporre anche agli altri i propri valori, di rappresentare Il Bene, vuoi perseguitandoli, vuoi costringendoli in una rete di norme e di divieti illiberali, è un tratto largamente comune, sconosciuto forse al solo buddismo, almeno quello originario.
C'è stata nel Novecento, soprattutto in Occidente, una rivoluzione straordinaria che ha portato le donne a essere finalmente considerate come persone, al pari degli uomini, titolari di diritti, di relazioni, soggetti e non più oggetti di un progetto di vita. È stato uno dei passaggi più importanti per dare concretezza alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ma è anche uno dei passaggi più ardui della convivenza plurietnica in Occidente, come della difesa della persona a Oriente. Quel che non ho mai capito, tanto per fare un esempio, è perché mai debbano essere le donne a portare il velo. Quali che siano le contorsioni cultural-sociologiche per giustificarlo, ecco un segno, un simbolo di una condizione di inferiorità con cui una parte del genere umano ne sottomette un'altra. Anche nel caso in cui la soggezione è accettata e giustificata dall'interessata. Nella citata Dichiarazione de Il Cairo sui diritti umnai nell'Islam – che è poi un documento più avanzato delle concrete pratiche adottate in molte società islamiche - la donna, pur circondata da rispetto formale, continua ad essere un accessorio del marito.
Il comunitarismo islamico è piuttosto diverso da quello delle teorizzazioni occidentali che si rifanno allo stesso filone, eppure c'è qui una deriva comune del mondo, in cui la piccola appartenenza (comprendente anche tradizioni sociali millenarie) e i temi identitari non solo fanno a pugni con la dimensione planetaria dei problemi da affrontare ma minacciano la libertà della persona, la sua autonomia. Della persona, non dell'individuo, che è invece una dimensione egoistica e astratta dello stare nel mondo.
Penso che quello della neutralità laica dello Stato e dell'autonomia delle persone (delle donne, in particolare) siano due questioni sulle quali è inevitabile concentrare il confronto, speriamo sotto forma di dialogo.
Tutti temi, questi ultimi, su cui sarà bene tornare in modo più approfondito.
Nota 1: Su questi temi storiografici rimane fondamentale la raccolta di saggi a cura di Jacques Le Goff, La nuova storia, Milano, Mondadori, 1990, che però è ormai fuori commercio. [ritorno]
Nota 2: H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Torino, Einaudi, 2002. Il libro ha avuto un'influenza notevole nel pensiero ecologista. Naturalmente, le riflessioni dell'autore sono ben più complesse del sintetico giudizio riportato, ma – alla fine – le conclusioni politiche sono esattamente quelle riportate. [ritorno]
Nota 3: Il tema è stato già affrontato nel precedente Labirinto numero 8 che, recensendo il libro di Joseph E. Stiglitz, La globalizzazzione e i suoi oppositori, Torino, Einaudi, 2003, tratta anche del fenomeno della globalizzazione [ritorno]
Nota 4: Vedi la recensione del libro di Angelo Del Boca, Italiani brava gente, Padova, Neri Pozza, 2005. [ritorno]
Nota 5: Sulla questione dell'influenza della Prima guerra mondiale su tutto il Novecento si veda il mio e-book Prospettive del Novecento. Il nodo della Grande guerra. [ritorno]
Nota 6: H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2004 [ritorno]
Nota 7: Consiglierei, per approfondire questo aspetto del problema, di leggere il libro di P. Berman, Terrore e liberalismo. Perché la guerra al fondamentalismo è una guerra antifascista, Torino, Einaudi, 2004, di cui non condivido però la tesi principale e, in particolare per il Medio Oriente, quello più recente di Robert Fisk, Cronache mediorientali. Il grande inviato di guerra inglese racconta cent'anni di invasioni, tragedie e tradimenti, Milano, il Saggiatore, 2006. [ritorno]
Nota 8: Un recentissimo libro di Orlando Franceschielli, La natura dopo Darwin. Evoluzione e umana saggezza, Roma, Donzelli, 2007 affronta il problema in modo sistematico e efficace. [ritorno]
Nota 9: E. J. Obsbawn, Il secolo breve 1914-1991. L'epoca più violenta della storia dell'umanità, Milano, Rizzoli, 2000. [ritorno]
Nota 10: Per esempio, ne ha trattato Federico Rampini nel suo L'impero di Cindia, recensito in un precedente Labirinto. [ritorno]
Nota 11: Vedi la recensione di J.E Stiglitz, I ruggenti anni Novanta, Torino, Einaudi, 2005. [ritorno]
Nota 12: Il Vaticano ha la veste di Osservatore permanente presso l'ONU, non in quanto Stato, non avendone le caratteristiche riconosciute, ma in quanto ente religioso. Uno status concesso alla sola Chiesa cattolica, "che si trova così avvantaggiata rispetto ad altre religioni o correnti di pensiero non religioso che non hanno un territorio a propria disposizione". [ritorno]
Torna in biblioteca
Torna all'indice dei labirinti